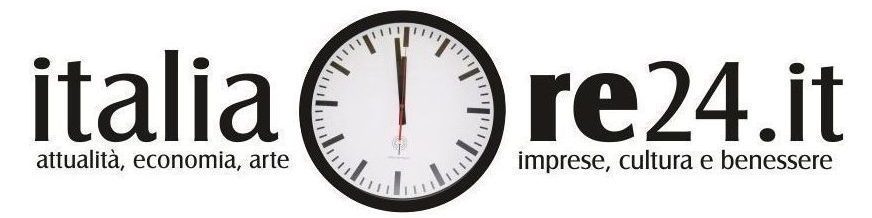di Riccardo Maggiolo Fondatore del Progetto Job Club | da Huffpost
Evidentemente, oltre un anno di lockdown – seppure a fasi alterne – non ci è bastato. Non è stato sufficiente notare, mentre stavamo a casa in cassa integrazione o in smart-working, che al supermercato frutta e verdura e in generale il cibo fresco continuavano ad arrivare. Non ci è bastato, nei momenti più bui della pandemia, realizzare quanto non solo medici e infermieri, ma anche badanti, assistenti sociali, insegnanti siano fondamentali per la nostra società. Ora che stiamo per metterci alle spalle un altro inverno difficile e iniziamo a tornare gradualmente e con cautela alle nostre care libertà, sembra che ci siamo scordati di tutto questo: siamo tornati a pensare al lavoro di cura o coltura come lavoro secondario, subalterno, superato.
Basta guardare ai primi numeri degli investimenti previsti Piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU , per rendersene conto. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura si accaparreranno oltre 46 miliardi di euro; la rivoluzione verde e la transizione ecologica quasi 69 miliardi; le infrastrutture per la mobilità sostenibile quasi 32; istruzione e ricerca oltre 28. E per carità, intendiamoci: va benissimo, anzi è fondamentale investire in questi settori, poiché sono quelli capaci di dare maggior ritorno agli investimenti e in prospettiva di generare nel lungo periodo occupazione e sostenibilità. Però.


Però, un po’ colpisce che il pilastro che fin qui ci ha tenuto a galla e che ancora in futuro dovrà farlo, la Salute, si prenderà “solo” 20 miliardi, mentre al settore che rischia di far saltare a breve il banco, l’inclusione e la coesione sociale, siano destinati “solo” 28 miliardi. Già, perché i numeri sono da far tremare i polsi: il 2020 ha prodotto oltre un milione di nuovi disoccupati, e all’orizzonte si profila un’altra ondata con la rimozione del blocco di licenziamenti. Nel mentre, per l’Istat sono oltre due milioni le famiglie oggi in stato di povertà assoluta – che non è una condizione cosìterribile come sembra dal nome, ma certo non è un bel segnale.
Un’emergenza sociale senza precedenti di cui, finalmente, stiamo cominciando ad accorgerci. Solo che sembriamo totalmente impreparati ad affrontarla. E non tanto per il ritardo con cui ci muoviamo, ma soprattutto per la visione completamente infondata che spesso abbiamo del lavoro e del suo mercato. Perché si sente parlare di skill shortage, di formazione per le competenze digitali, di industria 4.0, di digital transformation, di potenziamento delle piattaforme di matching… Quando tutte queste cose, per quanto importanti, hanno dei ruoli totalmente marginali rispetto al panorama lavorativo italiano (e non solo).
Qualche giorno fa l’Anpal – Associazione nazionale politiche attive del lavoro – ha dato accesso ad alcuni dei loro set di dati sul mercato del lavoro italiano. Sfogliarli e approfondirli è un bagno di realtà. Guardando ai dati del 2019 – quindi dell’ultimo anno “normale”, non afflitto dalla pandemia – si nota che il numero di gran lunga maggiore di assunzioni è avvenuto in agricoltura, con quasi 1 milione 100mila contratti per braccianti. Seguono 350mila commessi, 293mila camerieri, 248mila “addetti agli affari generali” e 182mila baristi. Poco sotto nella classifica si possono trovare varie categorie di personale non qualificato: nell’edilizia (146mila), nelle pulizie (144mila), nella logistica (143mila), nella ristorazione (114mila). Per arrivare alla prima categoria di lavoratori ad alta qualifica bisogna arrivare agli specialisti educativi (90mila), agli agricoltori specializzati (58mila) e al personale sanitario qualificato (48mila). Gli analisti e progettisti software? Meno di 22mila assunzioni. I tecnici programmatori? Poco più di 14mila. Tecnici esperti? Meno di 13mila.
Certo, si potrebbe sostenere che le assunzioni non ci sono proprio perché mancano i lavoratori qualificati, e si avrebbe ragione. Si potrebbe anche dire che i lavori poco qualificati sono quelli più esposti alle assunzioni temporanee, e quindi il numero assoluto di assunzioni lievita, e anche si avrebbe ragione. Ma francamente pare davvero difficile, anche considerando questi fattori, giustificare l’enorme divario che c’è tra una narrazione del mondo del lavoro tutto proiettato verso il digitale e la specializzazione tecnica e una realtà molto più legata ai bisogni concreti della popolazione. Tra un mercato del lavoro apparentemente dominato da siti internet e agenzie e una realtà invece tutta centrata sulle relazioni fiduciarie e le connessioni umane.
D’altronde, sempre guardando ai dati del 2019, il settore che ha registrato la migliore performance nel differenziale tra assunzioni e licenziamenti sono gli alberghi e i ristoranti (+107mila), seguiti da istruzione e sanità (+95mila) e industria (+69mila). Inoltre, sono stati i lavoratori qualifiche “medie” a costituire quasi il 50% delle assunzioni, oltre a presentare il saldo a fine anno più positivo (277mila), mentre le qualifiche basse hanno riguardato il 29% dei contratti (saldo: +123mila) e quelle “alte” il 22% (saldo: +87mila) – ma, guardando ai numeri di prima sulle professioni, probabilmente per queste ultime non stiamo parlando di tecnici digitali o industriali iper-qualificati.
Insomma, nel dibattito pubblico c’è un grande pregiudizio verso le professioni di “cura” e “coltura”. Le si ritengono sorpassate, residuali, quando invece non solo rappresentano la colonna portante della nostra società, ma hanno probabilmente un futuro abbastanza solido davanti. Se l’automazione impatterà sull’occupazione, infatti, è probabile che essa colpirà le competenze medie tecniche piuttosto che le professioni di cura o coltura – provate voi a far fare l’insegnante d’asilo a un robot o a far raccogliere migliaia di fiori di zucca a una macchina. Accecati da una narrazione imperante di un futuro iper-tecnologico inevitabile, stiamo spingendo le persone proprio verso quei lavori che forse spariranno nel futuro; anche perché visto che spesso vi si approcciano controvoglia, faticano a raggiungere livelli d’eccellenza e ad aggiornarsi.
Un rischio, questo, che rischia di colpire una categoria particolare: le donne. Esse, infatti, hanno una naturale predisposizione al lavoro di cura, e nonostante ciò sono quelle che più di tutti oggi subiscono pressioni culturali per andare a occupare posizioni manageriali o tecniche. Sebbene le donne abbiano subìto assai meno le conseguenze della pandemia di quanto non si sa raccontato in qualche pigra analisi (qui lo spiegano bene tre ricercatrici) sono comunque state colpite più degli uomini: spingerle a studiare management o scienze STEM quando abbiamo e avremo sempre più un disperato bisogno di infermiere, badanti, insegnanti, educatrici non sembra una mossa molto avveduta. Il punto è invece che queste professioni vanno riconosciute sia socialmente che economicamente molto di più: al fondo della discriminazione di genere c’è una discriminazione di ruolo, e senza risolvere la seconda probabilmente non ci lasceremo mai alle spalle la prima.
Ma, infine e soprattutto, ora c’è da ragionare nel breve periodo. Già ci sono già un milione di disoccupati in Italia, e probabilmente a breve se ne aggiungeranno altrettanti. Queste persone non possono aspettare che le magnifiche sorti e progressive del futuro digitale si inverino: bisogna collocarle già nei prossimi mesi, e dovremmo quindi puntare su settori e qualifiche che i dati ci dicono essere i più ricettivi. E poi, certo, continuare a investire su innovazione tecnologica e transizione ambientale, ma non mettendole al primo posto dei pensieri e dei portafogli. A che serve avere la mobilità sostenibile o le fabbriche digitali se milioni sono senza lavoro, i fragili rimangono senza cura, e la povertà dilaga? Non ci consolerà molto guidare auto elettriche in nuove autostrade “green” se, uscendo di casa, troveremo bande di disperati pronti ad assalirci e masse di poveri che dormono per strada.