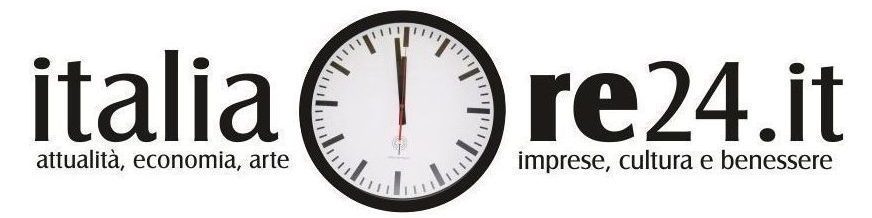Nel giorno del corteo pacifista che oggi sfilerà a Roma, Francesca Mannocchi, autorevole collega giornalista inviata di guerra, che in Ucraina sta lavorando dall’inizio del conflitto rischiando la vita, ha scritto dalle pagine de “La Stampa”, a tutti i pacifisti d’Italia. A quelli, soprattutto, per i quali la pace si potrebbe affermare in poche ore: semplicemente togliendo all’Ucraina la possibilità di difendersi e difendere il proprio territorio con una resa incondizionata ed un “cessate il fuoco”. Il suo diventa così un appello affinché chi parla di pace a tutti i costi ma spesso “senza senso e conoscenza” e senza considerare che “non c’è pace senza giustizia” possa comprendere che in gioco qui c’è la democrazia e la libertà dei popoli del mondo.
«Quando si parla di pace nel contesto di questa sanguinosa e drammatica guerra istigata dalla Russia, alcune persone non vogliono riconoscere un semplice fatto: non esiste pace senza giustizia (dal discorso di accettazione del Peace Prize of the German Booktrade dello scrittore ucraino Serhiy Zhadan il 23 ottobre). Ho trascorso le ultime settimane in Ucraina, spinta lì dagli attacchi che il 10 ottobre hanno riportato il terrore nelle strade di Kyiv, che hanno colpito ancora Dnipro e Zaporizhzhia uccidendo venti persone e ferendone più di cento. Il mondo ha guardato a quegli attacchi come a una fase nuova del conflitto, la strategia del terrore, si dice. Ed è vero, funziona così. Si colpisce la vita quotidiana, si condannano i civili a uno stato di tensione e privazione permanente sperando che, alla lunga, persino il più solido degli animi ceda e chieda a chi è chiamato a prendere decisioni, di fare un passo indietro, concedere qualcosa all’avversario, consegnare all’invasore ciò che chiede. La strategia del terrore, si è detto. Come fosse un dato inedito e invece, semplicemente, ci eravamo distratti, perché inchiodati alla cronaca del presente, abbiamo perso di vista i disegni imperiali del regime di Putin che seguivano un calendario dilatato.
«O la resa o la morte» è il metodo putiniano della guerra. L’aveva detto durante l’assedio dell’Azovstal, a marzo. «Che non entri e non esca nemmeno una mosca» è stata la regola che Putin ha imposto sull’ultima battaglia di Mariupol: l’arma era l’assedio, la conseguenza la fame, l’effetto la resa. La guerra allora era iniziata da otto settimane e già c’erano tutti gli elementi per capire che circondare e affamare le persone fossero i tasselli di una strategia precisa.
Le truppe russe avevano già devastato terreni agricoli, distrutto attrezzature, minato i terreni fertili, danneggiato le rotte di rifornimento, bloccato i porti, tagliato l’elettricità e distrutto le centrali elettriche, interrotto le forniture di acqua e di gas, distrutto magazzini di cibo, e depositi alimentari. Colpito consapevolmente i mezzi dei corridoi umanitari e le code dove le persone aspettavano la distribuzione di pane e aiuti alimentari, ucciso volontari, massacrato civili.

Nelle settimane successive, era aprile, ero a Bucha. Ho visto i cadaveri in strada, ascoltato i racconti dei civili torturati, ho ascoltato le vedove di uomini giustiziati sulla porta di casa, visitato anziani colpiti alle gambe e lasciati marcire di dolore nelle cantine, anziani rimasti senza gambe, amputate perché non c’era più niente da fare. Li ascoltavo mentre qui, in Italia, alcuni di quelli che invocavano la pace, negavano le stragi di Bucha, negavano le evidenze della strage del teatro di Mariupol. Sono passati i mesi, a quei cadaveri in strada, che erano lì, lo so perché ci ho camminato in mezzo, ha reso giustizia l’indagine giornalistica, ha reso giustizia la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite i cui esperti hanno concluso che in Ucraina siano stati «senza dubbio» commessi crimini di guerra. I tifosi della pace-come-resa dell’Ucraina che avevano negato la responsabilità russa su quegli eccidi, però, non si sono mai scusati. Oggi, probabilmente, saranno in piazza con la bandiera arcobaleno.
Ho osservato l’Ucraina per settimane nella maestosa luce che ha la città quando la bella stagione staffetta con l’autunno, ho cercato di cogliere negli sguardi dei passanti cosa sia abitudine al conflitto, come la consuetudine alla paura modifichi la ritualità del quotidiano e insieme i connotati dei volti, ho scoperto che la guerra fa al viso di un uomo quello che il mare e il vento fanno agli scogli, li consuma e insieme li definisce.
Sono salita sui tetti degli edifici colpiti, incidentalmente si direbbe, così come si direbbe che i morti siano collaterali. Ho guardato le città dall’alto, e lì mi è stato chiaro cosa provochi un missile quando colpisce una centrale elettrica e un ponte, cosa produca quando danneggia una scuola, e quando i vetri di una finestra si frantumano sul corpo di un’anziana mentre cuce a maglia con gli aghi e i gomitoli, dritto rovescio, dritto rovescio e poi, improvvisamente, è colpita da una scheggia e muore. Dopo aver incontrato gli occhi sfiniti dei sopravvissuti mi sono domandata quale fosse – se c’era – un modo rispettoso di chiedere agli ucraini cosa sia per loro la parola pace, oggi, mentre qui, in Italia, imbizzarrisce il dibattito tra pacifisti storici (e improvvisati) e i difensori del sostegno armato al popolo ucraino.
La prima cosa che ho capito, tessendo le risposte che ho ricevuto da nord a sud, da est a ovest, da soldati e civili, da attivisti e bambini è che pace, lì, sia una parola imperfetta.
Lo è per Stanislav, che è un soldato, e mentre sistemava le munizioni dell’obice di cui era responsabile mi ha detto che pace per lui è sposare la sua fidanzata, fare dei figli, comprare un barbecue e invitare i suoi amici a vedere la partita, in tv, la domenica. Ma che non c’è pace senza libertà.
Pace è una parola imperfetta anche per Liljia, che ha sessant’anni ed è tornata a vivere a Irpin. Di madre e padre russi, vive a Kyiv da sempre, suo padre è sepolto in Crimea e lei non può andare a piangerlo sulla tomba perché la Crimea è occupata da altri russi. Quando le ho chiesto cosa significasse per lei la parola «pace» mi ha detto che sta imparando a vivere dentro la guerra. Ha risposto così, dopo una pausa che è servita a disegnarle sul volto il sorriso di chi ha capito che non finirà presto, che niente sarà – comunque – più come prima, anche se le armi tacessero domani. È la saggezza dell’esperienza delle vittime che dovrebbe indicare la via e dare le parole d’ordine a chi scenderà in piazza, oggi. Le parole come quelle di Liljia, che qui consegno testuali: «Noi voltiamo le spalle ai russi perché loro hanno voltato le spalle a noi. Dobbiamo solo imparare a viverci dentro. I tempi in cui eravamo sangue dello stesso sangue sono passati e non torneranno mai più. Nessuno vuole tornare a quello che esisteva prima del 1991, pace per noi è andare da qualche parte nel futuro, ma i russi invasori che volevano un unico grande Paese hanno costruito un’unica grande prigione». In questi otto mesi di invasione russa in Ucraina il valore delle parole dei testimoni è stato progressivamente indebolito, fino ad essere quasi del tutto ignorato, perché la portata delle evidenze di cui ci rendevano consapevoli non poteva che richiamare a una responsabilità collettiva, cioè solidarizzare con gli invasi, aiutare le vittime a difendersi, e cioè a liberarsi dall’invasore e chiedere giustizia. Per i giustiziati, i torturati, le donne stuprate, gli anziani lasciati morire di dolore, e risarcimenti per i ponti distrutti, le strade danneggiate, le scuole rase al suolo, le fosse comuni, le condotte idriche frantumate.
Perché, in una guerra di invasione, val la pena ricordarlo a chi scende in piazza, funziona così. Sono gli invasi che vivono nei bunker, scendono in metropolitana con i sacchi a pelo per paura di morire schiacciati dal tetto di casa, solo da un lato del confine si vive con le sirene antiaeree nelle orecchie dal 24 febbraio, è per questo che da un lato del confine non può esserci pace senza giustizia.
La demarcazione tra pace e giustizia attraversa l’opinione pubblica da mesi, come se i due campi anziché essere necessari l’uno all’altro fossero di segno opposto.
Il conflitto in Ucraina si sta trasformando in una lunga guerra di logoramento, e rischia di diventare anche la linea di demarcazione tra una idea di Europa che rischia di frantumarsi sotto il peso di questa spaccatura dell’opinione pubblica, Putin lo sa. È la condotta di ogni fanatismo, creare divisioni nel campo avversario e riempire il vuoto che si è creato seminando odio. Ecco perché la strategia del terrore di Putin, riguarda anche chi scenderà in piazza oggi. La manifestazione di oggi chiama al negoziato, alla pace, sacrosanto. Attenzione però a non confondere la pace con la debolezza di aver ceduto al ricatto di un dittatore. Alcuni sostenitori dello stop all’invio di armi ritengono che sfilandosi dalla guerra diminuiranno i combattimenti e si morirà di meno. Anche questo è sacrosanto. Invito, però, i partecipanti – soprattutto i tanti che spinti da nobili intenzioni riempiranno strade e piazze – a chiedersi quanto siano diventati strumenti di una parola così pura ma usata, oggi, sul ring di leader perdenti e in crisi di identità politica che provano a raschiare un magro consenso, scendendo in piazza con le bandiere arcobaleno. Viene da pensare, con un realismo dettato dall’esperienza e non dal pregiudizio, che sfilandosi dalla guerra, oggi, diminuirebbero la spinta dei rifugiati sui nostri confini (leggasi sul nostro welfare) e poi, certamente, le bollette del gas. Diminuirebbe la paura dei cittadini del costo economico di questa guerra di liberazione. Ma verrebbero meno anche tutti i valori che fino ad oggi hanno sostenuto la nostra idea di democrazia, autodeterminazione e libertà. La nostra idea di mondo giusto, l’unico nel quale una vera pace è possibile».